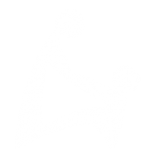di PAOLO VIANA
inviato a Cremona
Nessuno sa bene cosa sia, finché non varca quella porta. All’ombra del Torrazzo, ma soprattutto nelle campagne che sanno di erba e di stallatico, lo chiamano ospizio oppure ospice, esattamente come lo scriviamo. Chi è andato in vacanza all’estero lo pronuncia all’inglese: ospais. I padri camilliani, che conoscono il loro gregge, hanno scritto, bello e in grande «Cure di supporto » sulla vetrata che separa i luoghi della cura da quello dell’attesa. Un gesto di gentilezza lessicale. “Hospice” pareva troppo lontano dalla quotidianità della Bassa cremonese persino a loro, che hanno un rapporto speciale con l’Oltre. « Non puoi capire cosa succeda qui dentro finché non ci vivi, esattamente come non puoi capire cosa voglia dire essere un malato terminale finché non lo sei» spiega Massimo Damini, responsabile delle cure palliative. Uno di quei medici che applicano i protocolli ma non si staccano mai dal paziente. «Quell’uomo è un santo – dice una malata – . Mi ha tolto un dolore atroce, atroce». Damini forse non è ancora un santo ma certamente è un bravo palliativista. Un uomo che non si arrende, che ascolta e non giudica: « Anche negli ultimi giorni, forse soprattutto quando la sorte sembra segnata – ci spiega – si deve tenere vivo il patto tra il medico e il paziente, perché in quell’alleanza che produce scelte consapevoli si compie davvero il destino di una vita». L’eutanasia? « Ne ho sentiti tanti chiederla appena entrati e poi lavorare con noi per strappare giorni ai giorni, dare un senso a quest’esperienza. Non la pratico, non giudico chi me la chiede, non rispondo che è illegale – e lo è – ma dico che possiamo fare altro per lui o lei che soffre, ed è vero. La paura di soffrire e la perdita di dignità più della morte stessa annichiliscono la mente. Ciò detto, rispetto anche quella richiesta disperata e non so cosa proverò io, quando sarà la mia ora». Come dargli torto? Per quanti discorsi si facciano, solo “alla fine” puoi sapere se sei stato davvero coerente coi valori che professi.
Ma torniamo a ciò che si dice in un hospice. Qui dentro, nei piccoli gesti quotidiani della sofferenza e della cura, acquisisce senso una parola che, curiosamente, in un luogo come questo nessuno pronuncia mai: morte. Aggiunge Damini: «Le cure palliative non si fanno da soli, serve un team strutturato, competente e motivato capace di lavorare in sintonia». Un paziente lavoro di tessitura sui bisogni della persona malata, cui attende un’intera équipe formata da coordinatrice, infermieri, oss, psicologa, assistente sociale, assistente spirituale e religioso. Dentro un hospice questa è la filosofia e anche la prassi, si lavora insieme al malato per dare senso a un futuro che non riesce più a essere detto. Questo silenzio etimologico sul fine vita può sembrare scontato, allorquando il dolore ci sovrasta, mentre è la conseguenza di un’azione terapeutica. Il patto tra medico e paziente contempla anche l’impegno a mettere in pausa l’ineluttabile. Damini lo inquadra così: «Ogni giorno cerchiamo forme di compensazione alla violenza che ci capita addosso».
Ma Eligio lo spiega ancora meglio. All’inizio del percorso questo meccanico ripeteva, come tanti, «perché proprio a me?» Uno stupore motivato, motivatissimo. Eligio era un pezzo d’uomo capace di smontare un aratro e il motore di un trattore. Suo figlio fa lo stesso mestiere, sempre in officina, ma usa solo il computer. Eligio è fiero di quel suo figlio studioso, ma anche molto preoccupato per la bella casa di Corte dei Frati e per quel giardino di alberi da frutta che nessuno accudisce più. Guarda il giovane aggirarsi nella stanza e ci bisbiglia: « Non ha mai preso in mano una zappa, adesso cura lui il mio orto... non so proprio come faccia». La compensazione di Eligio è la libera uscita. Ogni settimana Damini lo manda a casa insieme alle sue flebo, al catetere e a tutto ciò che aiuta uno stomaco che non vuol più funzionare. Un giorno in famiglia, a controllare le piante del giardino e la salute dell’orto. Un piccolo mondo antico andato in frantumi dopo il pranzo di Natale. «Sono riuscito ancora a mangiare l’anguilla – ci racconta – ma dopo una settimana mi è passato l’appetito. Si pensava a un’ulcera ». Un esame, e dal Natale si è passati al Venerdì Santo. «Ora il mio futuro è incerto, ho già perso dieci chili; se non mi riprendo non mi possono operare e la mia vita finisce qui, a settantaquattro anni». Rimpiange gli amici – alla prima “libera uscita” li ha riuniti tutti nel garage di casa – ma ciò che più lo affligge è il dolore dei familiari. « Mio figlio non si dà pace, mia moglie è distrutta, cosa farà in quella grande casa?» Pensieri da pater familias.
È vuota anche la casa di Maria Grazia, a Pizzighettone. Ci viveva con il fratello disabile. Ha dovuto ricoverarlo in una Rsa, quando ha scoperto «il brutto male», e non se ne dà pace, perchè Giorgio in quella residenza c’è morto, consumato da una malattia neurodegenerativa. Ogni giorno Maria Grazia piange la sorte del fratello. «So che devo preoccuparmi per me stessa – ammette – ma la mamma ci ha insegnato il senso del dovere e l’attaccamento alla famiglia». Non si sono mai sposati, Sergio e Maria Grazia. Hanno coltivato entrambi la vocazione di custodire la famiglia dei genitori. Il loro unico grande amore. «Come ogni famiglia, dopo la morte di papà e mamma, abbiamo deciso tutto insieme – precisa la donna –, quindi anche il nostro ricovero». E racconta le lunghe serate a parlarne con Sergio, l’ipotesi di un ricovero in uno dei grandi ospedali milanesi specializzati nella cura del cancro, infine la scelta di restare a Cremona, vicini. Neppure adesso che il suo corpo non sembra più suo Maria Grazia cessa di sentirsi in colpa per averlo lasciato a morire da solo, in un ricovero per anziani. Nei giorni del Covid. Solo il pensiero che l’équipe dell’hospice si occuperà di lei sembra quietarla. Questa è la sua seconda casa, ci dice. Non prova il desiderio di rivedere la prima. Troppo vuota per parlarle di famiglia. Un amore irripetibile, bello e pesantissimo, cui ha sacrificato tutto. « Ma qui dentro – ci dice – mi aiutano a pensare anche a me stessa». E questa è la sua compensazione.
Scarica l'articolo di Avvenire