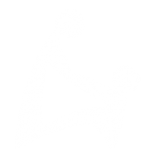di MASSIMO ANGELELLI
A Betania, succede qualcosa di usuale, qualcosa che può accadere facilmente ancora oggi. Sei in viaggio e chiedi ospitalità a persone che conosci. Il gruppo in cammino è ospitato a casa di Marta. Saranno state oltre una quindicina di persone: il Maestro, i Dodici più alcune donne che erano con loro (cfr Lc 10, 38-42). È questo lo scenario evocato ne I cantieri di Betania, il documento guida per il secondo anno di Cammino sinodale predisposto dalla Cei. Le principali parole chiave evocate dal documento sono: cammino, ascolto, accoglienza, ospitalità, servizio, casa, relazioni, accompagnamento, prossimità, condivisione. Tutte parole note alla pastorale della salute e molto care, perché segnano stile e metodo del prendersi cura delle persone, ma che a quasi tre anni dall’inizio della pandemia chiedono di essere nuovamente declinate e pensate in un tempo attuale che ha visto cambiare abitudini, percezioni, stili di vita. Siamo cambiati, pur non volendolo. Forse sarebbe opportuno riconoscere che siamo stati cambiati.
Per questo motivo, fortemente provocati, abbiamo posto alla grande rete della pastorale della salute in Italia questi interrogativi. In particolare, nel secondo dei Cantieri di Betania, quello «dell’ospitalità e della casa», ci sentiamo coinvolti. L’intuizione originale di san Giovanni di Dio è proprio il carisma dell’ospitalità, della volontà di accogliere e accudire i più bisognosi. L’ospedale [ hospitale] è il luogo dove cerchiamo la cura dei professionisti che, forti delle conoscenze scientifiche acquisiste, la modulano secondo i bisogni della persona malata. La casa è il luogo della protezione e della sicurezza, il luogo amico in cui le relazioni sono tra le più forti che viviamo. Al tempo stesso è anche il luogo dove la mia fragilità è più protetta, dove vivere l’esperienza della ma-lattia è più sopportabile, perché circondato da luoghi, ricordi e persone rassicuranti. La vulnerabilità che è generata dalla malattia può essere riportata a un equilibrio necessario per poter continuare a vivere.
Questi due luoghi – l’ospedale e la casa –, reali e simbolici, devono sempre più essere vicini e somigliarsi, perché la persona ha bisogno di luoghi e volti amici per poter affrontare meglio le sue sofferenze. In un interscambio virtuoso dobbiamo far sì che gli elementi e i percorsi della cura possano essere vissuti al domicilio, così come, quando dovesse essere necessario, nei luoghi della cura ci si possa sentire un po’ come a casa, con luoghi adeguati e con la presenza degli affetti che rassicurano e accompagnano. La chiamano umanizzazione delle cure, segno che un po’ oggi rischiano di essere disumanizzate. Perché la peggiore delle esperienze è vivere la malattia in solitudine. Nel Cantiere dell’ospitalità e della cura ci viene chiesto di «approfondire l’effettiva qualità delle relazioni comunitarie e la tensione dinamica tra una ricca esperienza di fraternità e una spinta alla missione che conduce fuori. Si interrogherà poi sulle strutture, perché siano poste al servizio della missione e non assorbano energie per il solo auto-mantenimento, e dovrà verificarne sostenibilità e funzionalità ». La mente va veloce alla qualità delle relazioni che intercorrono tra i tre protagonisti principali della cura: la persona malata, i curanti e gli affetti più cari. Tutti protagonisti, tutti necessari, e in particolare tutti chiamati a fare il massimo sforzo affinché venga posto il tema della relazione come componente essenziale del percorso di cura. La persona malata ha bisogno di essere curata e di sentirsi curata. Tutti i professionisti della cura sentono il bisogno di essere riconosciuti nel loro ruolo di persona «che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell’ambiente ». Anzitutto persona, poi anche professionista della cura. Le persone accanto al malato, in virtù del legame relazionale che nutrono, non possono e non devono essere escluse dal suo vissuto. Appare evidente, invece, che sono soggetti che possono svolgere un ruolo importante per il sostegno all’esperienza del sofferente. È opportuno sottoporre a una verifica approfondita la qualità delle nostre relazioni nei contesti della cura, rimuovere rapidamente gli ostacoli per poter creare luoghi in cui sia evidente che si cammina insieme, per il bene del più vulnerabile.
Una riflessione ampia, serena e colma di parresìa, inoltre, dovrà maturare proprio sul tema delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di origine cattolica e di ispirazione cristiana, laddove la domanda non potrà essere orientata solo al tema della sostenibilità e funzionalità, questione piuttosto evidente. Ci si dovrà interrogare molto anche sulla domanda se queste strutture siano ancora segno profetico di una Chiesa che si fa prossimo agli invisibili e agli irraggiunti da un sistema di offerta sanitaria che tende a escluderli. Quanto le nostre strutture possono definirsi testimonianti di un Vangelo che propone in modo prevalente l’imperativo di prendersi cura (amarsi) gli uni con gli altri, privilegiando i meno amati, i meno inclusi?
Sembrano troppe domande per pochi mesi di Cammino sinodale, ma la necessità di ricercare le risposte ci imporrà di continuare a camminare, insieme, fino a trovarle.
Direttore Ufficio nazionale per la Pastorale della salute
Scarica l'articolo di Avvenire