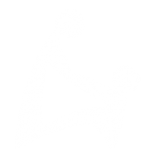Proprio mentre si celebrava la Giornata mondiale della salute mentale, il 10 ottobre, affiorava la storia drammatica di Shanti De Corte, la ragazza belga eutanasizzata secondo la legge, e su sua richiesta, perché depressa. Non ce la faceva più, ha chiesto allo Stato di farla morire, e lo Stato l’ha assecondata, con gelida efficienza. È giusto così? Non si può fare nulla quando chi non se la sente di vivere chiede di farla finita? La notizia è raggelante, e acuminati gli interrogativi che solleva. Cosa chiedono le tante Shanti che ci vivono accanto? (Il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani). E cosa possiamo fare perché non si arrivi, di caso di cronaca in sentenza, a una soluzione simile anche da noi, come un’ineluttabile approdo?
La notizia impone a tutti una riflessione su cosa si vuole ottenere quando si parla di fine vita e di possibili esiti legali di casi in cui la sofferenza sia percepita come “intollerabile”. Non è un aggettivo a caso, perché è il termine usato dalla Corte Costituzionale indicando al Parlamento nella sentenza 242 del 2019 questo criterio tra i quattro per poter accedere – se e quando a una legge nazionale si arriverà – alla morte assistita. Davanti agli occhi, insieme al volto sorridente di Shanti dalla sua pagina Facebook, ci resta l’idea che mentre si parla di “salute mentale” invitando a prendersene cura c’è chi i problemi che pone pensa di risolverli con un’iniezione. L’ultima. (èv)
Scarica l'articolo di Avvenire