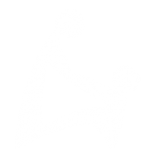Papa Francesco ammonisce che “il tempo è superiore allo spazio”, perché definisce un orizzonte all’interno del quale “custodire i processi” che si srotolano verso il futuro, superando i vincoli angosciosi di uno spazio che ci chiama a dominare nel presente ogni cosa.
L’attesa è una condizione che sperimentiamo inconsapevolmente fin dalla nascita: l’attesa insopportabile di una poppata capace di ripristinare l’omeostasi biologica alterata che ci ha spinto a emettere i primi vagiti di richiamo verso “l’altro che cura”, scolpendo nelle nostre memorie la relazione tra bisogno e suo soddisfacimento. Vita psichica e mentale non potrebbero essere senza lo spazio dell’attesa: l’ansia abita il tempo dell’attesa, a volte proteggendoci, a volte devastandoci. E la resilienza è l’adattamento finale che ciascuno di noi, in base alle sue caratteristiche e agli eventi, riesce a costruire nel tempo dell’attesa.
Ora, siamo immersi in un vivere dal tempo sincopato, accartocciato su se stesso, dove tutto deve essere realizzato nell’immediato, senza iato, prima che la vita ci sfugga e annulli la nostra esistenza in un oblio definitivo: nel villaggio contemporaneo, la trepida attesa del sabato è stata annullata, lo spazio del week- end dilatato per vivere un presente pieno di oggetti.
Questa distorsione spazio-temporale si è abbattuta in ogni meandro dell’esistenza: e così la salute, diventata benessere, cioè il diritto di “sentirsi bene” sempre e senza attesa, è diventata un oggetto di cui disporre.
Anche la cura dei figli, naturale fatica che affligge da sempre la specie umana, si è fatta affannosa: i bambini devono crescere in fretta, devono poter soddisfare ogni loro desiderio rapidamente, anche quelli proiettati su di loro dai genitori; gli adolescenti invece sono intrappolati in uno spazio senza confini e regole dove il crescere, naturalmente tumultuoso, è rallentato o anche bloccato. E quando i genitori collassano nella loro capacità genitoriale, allora i figli diventano “astioso fastidio” che frappone ostacoli non aggredibili al proprio desiderio immediato.
L’attesa è angoscia senza fine, il limite è impotenza tragica: il vivere è una frenetica somma di oggetti da possedere. E l’organizzazione sanitaria ci è finita nel mezzo, senza nemmeno accorgersene.
La salute non è più un processo, ma una condizione/oggetto da possedere come diritto: esami, visite, medicine, terapie, di tutti i tipi: tanti oggetti nel luccicante market che promette non solo salute, ma addirittura “ben-essere”. Le regole del mercato fanno il resto: basta poco per trasformare ciascuno di noi in “acquirente compulsivo” stimolato continuamente da miriadi di sollecitazioni che grazie agli smartphone non ci abbandonano nemmeno la notte: sfruttando la nostra compulsione siamo venduti al mercato affamato di dati, che così ci traccia e condiziona i nostri desideri.
In greco “therapeia” era sinonimo di servizio; in latino “curare” era un verbo intransitivo: “mi occupo di…”. Nella pratica contemporanea “curare” è diventato un verbo transitivo: curo la malattia, il sintomo, il “mal-essere”, attraverso una tecnicalità ardita ai limiti del transumano e oggetti (le terapie) sempre più numerosi, da possedere compulsivamente.
Però, anche se oggettivamente viviamo più a lungo e la dovizia di oggetti è sempre più numerosa, ci sentiamo sempre peggio: preoccupati per la nostra salute e ancora di più e legittimamente per quella dei nostri figli, arrabbiati per un sistema sanitario che non ci soddisfa come vorremmo e come crediamo legittimo debba essere.
“L’officina di produzione” – ossia il Servizio Sanitario – non riesce a soddisfare tutta la domanda: e così si generano le liste d’attesa.
Da molti anni ministri e assessori che si occupano di sanità e welfare combattono la loro intemerata battaglia contro le liste d’attesa: anche quando non si limitano solo a roboanti proclami o a manipolazioni contabili e immettono risorse specifiche e aggiuntive, la lunghezza delle liste non si riduce. Anzi! Bisogni di salute sempre nuovi si affacciano sul mercato aggiungendosi ai vecchi, peggiorando la situazione.
Saltato il sistema famigliare con le sue connessioni intra-generazionali in grado di operare un primo filtro alla domanda, spazzata via la capacità di accudimento che si era tramandata sapienzialmente di generazione in generazione, i genitori si trovano con i loro bambini, soli, senza esperienza, frastornati da miriadi di offerte di cura, costruite su misura per la loro naturale insicurezza, senza che in realtà nessuno si occupi davvero di loro. Ormai non chiedono nemmeno più un accudimento, perché “cablati” per credere che solo gli “oggetti di cura” li aiuteranno a crescere il loro bambino, sempre più “cosificato”: emozionale, costoso, programmabile a piacere e a volte anche acquistabile.
In questo turbinio di richieste, tutte sacrosante, anche se con cogenze e urgenze differenti, diventa una sfida davvero improba per un servizio sanitario universale riuscire a produrre tempestivamente tutti gli “oggetti di cura” richiesti: il tempo è un fattore spesso decisivo, nei bambini in maniera specifica.
Quando un bene non è disponibile nella quantità richiesta, fioriscono i mercati paralleli: chi può si getta nel privato per trovare le risposte che cerca.
Per chi non ha risorse, per chi è più fragile o marginale, quando la malattia non ha cura e ci costringe ad un lungo e faticoso processo di accompagnamento – di immediata evidenza nella condizione di disabilità specie nel bambino - rimane solo il servizio sanitario pubblico: sempre più stremato, disegnato per “produrre prestazioni” in risposta ad una domanda orientata mercantilmente in tal senso, percepito e vissuto da operatori e pazienti come fallimentare, perché quando la risposta deve essere davvero un “oggetto di cura”, è surclassato dalle dovizie e dalla rapidità del mercato privato; quando la risposta è “occuparsi dell’altro che ha bisogno”, dove il mercato privato furbescamente si eclissa, non ha più nemmeno le coordinate e il passo per saperlo fare. Incapace di capire che il “non-profit”, anche se ormai marginale, può essere un aiuto: pubblico non vuol dire statale; mentre rincorrere la sanità profit e peggio ancora chiamarla a sussidiarlo importandone anche le sue logiche di mercato, può solo portarlo al completo disfacimento: se è “pubblico”, cioè per tutti, non può essere mercato, se è mercato, non può essere “per tutti”.
Nel mentre, ci sono i bambini con bisogni di salute e di cura, bambini che necessitano di qualcuno che si occupi di loro e dei loro genitori. Subito, con la sollecitudine di “Maria che in fretta andò da Elisabetta che era in attesa del figlio”, perché i bambini nel crescere, anche biologicamente, costruiscono ciò che saranno: e il tempo fugge rapido specie per loro. Le attese, le mancanze di risposte, organizzazioni sanitarie inadeguate e “costruite sbagliate”, rubano ai bambini la speranza del futuro.
E’ necessario cambiare radicalmente la logica della risposta sanitaria, specie per le condizioni di fragilità e nelle fasi dello sviluppo: è urgente passare dal curare al prendersi cura, investire sulle professioni di aiuto, ridando dignità anche economica al loro ruolo, non perché “produttori di oggetti che aumentano la catena del valore”, ma perché “stanno accanto” nel divenire del tempo, con competenza specifica e tecnicalità adeguata - “dalla parte dei bambini” -, affiancando i genitori, intervenendo anche con la tecnologia quando serve, sapendo che la crescita di un bambino è un processo che si srotola nel tempo aprendoci al futuro, e che ha bisogno di accudimento, e anche di coccole, fin da subito, specie nella malattia.
La vita di ogni bambino è una scintilla che riempie di luce “la volta celeste”: basta alzare lo sguardo per accorgersene. E’ un delitto spegnerla con le bombe, annegarla in mezzo ai flutti, soffocarla con l’incuria e la fame, renderla asfittica fino alla sua scomparsa per mancanza di accudimento e di cure, violarla e manipolarla per farne “lampada” dei propri desideri.
“Custodire” queste scintille per dilatare il tempo e ridare speranza alla storia: anche alla nostra.